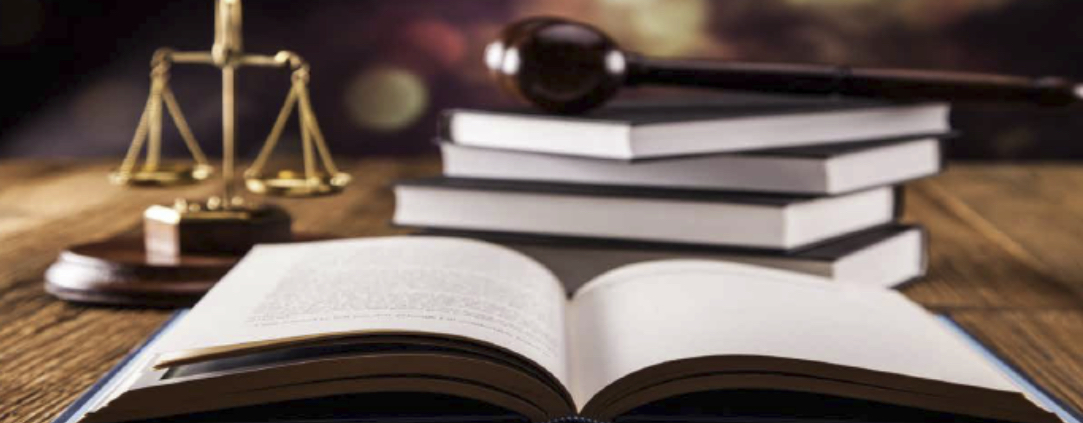Demansionamento e quantificazione del danno non patrimoniale
Tizio, dipendente in una società di telecomunicazioni, chiedeva accertarsi nei suoi confronti demansionamento ai sensi dell’art 2103 cod, civ in quanto le attività che egli stesso svolgeva non erano di semplice risposta al call center ovvero di attività svolte secondo iter definiti, bensì richiedevano conoscenze di natura tecnica di un certo spessore, che presupponevano dunque competenze ulteriori e specifiche.
Analizziamo dunque le implicazioni sottese al caso di specie alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
CONTESTO NORMATIVO
Come noto, per esaminare il caso in oggetto è opportuno soffermarsi sulla tematica del demansionamento attenzionata in relazione all’esercizio dello ius variandi.
L’interpretazione costituzionalmente orientata della versione post Jobs Act dell’articolo 2103, cod. civ., recupera il valore della professionalità del lavoratore, sancendo che l’esercizio dello ius variandi datoriale “non può, in ogni caso, consentire al datore di lavoro di mortificare il valore della professionalità del lavoratore, che è rappresentato, oltre che dal suo inquadramento contrattuale, anche, ed in pari misura, dall’esperienza, dalla preparazione e dalle competenze maturate nel corso degli anni. Tali elementi contribuiscono a creare un patrimonio indissolubile costituente il presupposto per il continuo sviluppo delle capacità lavorative.
Si tenga, tuttavia, presente che l’assegnazione a mansioni inferiori non si traduce in un’automatica dequalificazione professionale, in quanto tale fattispecie richiede una sottrazione di mansioni tale, per natura e portata, da comportare un sottoutilizzo delle capacità acquisite e un conseguente impoverimento della professionalità del prestatore di lavoro.
La tutela offerta alla professionalità dall’articolo 2103, cod. civ., interpretato in maniera costituzionalmente conforme, non può, dunque, spingersi sino a provocare la paralisi dell’esercizio dell’attività di impresa.
Ne consegue che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, “l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retributivo” è conforme al dettato dell’articolo 2103, cod. civ..
IMPLICAZIONI
Nella questione oggetto di approfondimento, nodo centrale della disamina risulta essere l’accertamento del demansionamento e la relativa ed eventuale qualificazione del danno.
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azione esercente attività di telecomunicazioni.
Il lavoratore citava in giudizio la società datrice di lavoro al fine di chiedere l’accertamento dell’avvenuto demansionamento e la conseguente condanna della società datrice alla reintegra nellemansioni precedentemente svolte nonché al risarcimento del danno alla professionalità da quantificarsi in via equitativa.
Il Tribunale adito, nella sua veste di giudice del lavoro, accoglieva le domande proposte. La datrice di lavoro proponeva appello.
La Corte territoriale confermava la pronuncia impugnata.
La società, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso della società.
Infine il Supremo consesso ha precisato, in ordine alla contestazione del quantum, che la ”liquidazione equitativa è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto”. Tali ipotesi, non risultano infatti ravvisabili nella fattispecie ove la misura dell’importo mensile è stato ancorato alla oggettiva differenza tra le mansioni cui il lavoratore era stato adibito prima dell’aprile del 2018 con quelle successive, in un contesto in cui si trattava di una nuova riassegnazione a mansioni di livello inferiore dopo un adempimento di un ordine giudiziale di riassegnazione alle corrette mansioni.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario infatti in caso di accertamento del demansionamento, il giudice applica un procedimento logico-giuridico c.d. trifasico, che, partendo dall’accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal lavoratore, si sofferma sull’individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dal contratto collettivo di categoria e si conclude con il raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda fase.
RISOLUZIONE SECONDO NORMA
Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento, il danno alla professionalità, da intendersi in senso dinamico, quale insieme di conoscenze teorico-pratiche che il lavoratore può progressivamente acquisire prestando la sua attività lavorativa, deve, dunque, essere dimostrato in giudizio dal lavoratore, il quale non deve necessariamente fornire la prova per testimoni, potendo anche allegare ex articolo 2729, cod. civ., elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Grava, dunque, sul dipendente l’onere di provare in giudizio la condotta dequalificante del datore di lavoro, il danno derivato nonché il nesso di causalità diretta ed esclusiva tra la predetta condotta e i danni subiti.
Il danno derivante da dequalificazione ha, dunque, portata plurioffensiva, in quanto suscettibile di dar luogo a una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica dellavoratore e, dunque, di manifestarsi nella sua dimensione patrimoniale (ad esempio, il danno da perdita di chance) nonché una dimensione non patrimoniale, risarcibile quando la condotta del datore violi interessi del lavoratore oggetto di tutela costituzionale.
Un danno di siffatta natura è, del resto, in grado di incidere sulla dignità professionale del prestatore, con conseguente lesione del diritto costituzionalmente tutelato alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e nell’ambito personale e relazionale.
RISOLUZIONE CASO PRATICO
Nella vicenda in oggetto dunque, il demansionamento consente di cogliere la particolarità del rapporto di lavoro che, assume una caratterizzazione necessariamente dinamica, in quanto ricomprende tutte le capacità, attitudini ed esperienze pratiche del lavoratore, che meritano di essere costantemente arricchite e sviluppate, dovendo ineluttabilmente evolversi di pari passo con i processi di modificazione dell’impresa e del settore.
L’offesa al bene della professionalità può, dunque, manifestarsi oggi in diverse forme: sia in senso “statico”, come mancato utilizzo delle conoscenze pregresse, sia in senso “dinamico”, quale perdita di occasioni concrete di progressione lavorativa e di accrescimento di conoscenze personali.
Il fenomeno dello svilimento della professionalità in senso dinamico interessa con maggiore frequenza i contesti assoggettati al costante progresso tecnologico e organizzativo.
In questo contesto, l’esercizio dello ius variandi, prerogativa gelosamente custodita dalla parte datoriale, non può esimersi dal bilanciare la riorganizzazione aziendale e la salvaguardia della professionalità dei lavoratori coinvolti nei processi organizzativi.