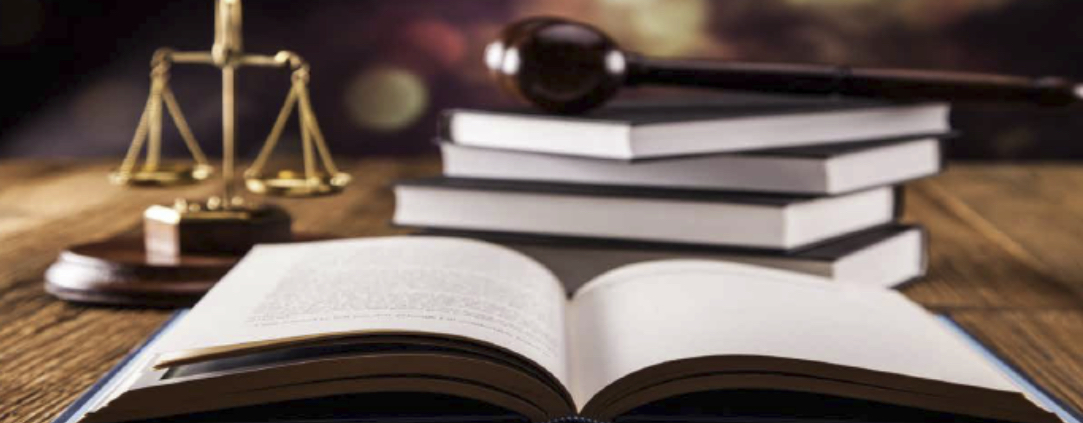Il reato di caporalato è configurabile per lo sfruttamento del lavoro intellettuale?
Tizia, presidente del CdA di una società cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, era stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto indagata per i reati di cui agli articoli 603-bis (c.d. caporalato) e 629 (estorsione aggravata), c.p., ai danni dei propri dipendenti, insegnanti di scuola secondaria.
L’imputazione era quella di aver sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, costringendoli, altresì, a restituire le retribuzioni ricevute, ovvero a lavorare sottopagati, con minaccia consistita nel prospettarne la mancata riassunzione in occasione di successivi rinnovi contrattuali.
Analizziamo la configurabilità dei suddetti reati e la legittimità o meno nel novero del reato di caporalato.
CONTESTO NORMATIVO
Come noto, l’articolo 603 bis c.p., introdotto dall’articolo 12 D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, la condotta di chi:
“1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Il disposto normativo individua specifiche condizioni costituenti indice di sfruttamento, in particolare:
“1) La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) La reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.
Sono, poi, previste alcune aggravanti specifiche, comportanti l’aumento della pena da 1/3 alla metà, vale a dire:
“1) Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) L’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.
Il reato, procedibile d’ufficio, è di competenza del Tribunale monocratico, con riferimento ai primi 2 commi della fattispecie, del Tribunale collegiale, per le ipotesi aggravate del comma 4. Prevede l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di violenza o minaccia, nonché l’applicabilità di misure cautelari sino alla custodia in carcere.
Alle sanzioni penali suddette si aggiungono, inoltre quelle amministrative e civili, previste, ad esempio, per il superamento del limite massimo dell’orario di lavoro, la costituzione del rapporto di lavoro presso l’utilizzatore o l’appaltante, la regolarizzazione del rapporto di lavoro in ipotesi di lavoro non dichiarato secondo la disciplina di contrasto al lavoro sommerso.
IMPLICAZIONI
Nella questione oggetto di approfondimento, Tizia, presidente del CdA di una società cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, era stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto indagata per i reati di cui agli articoli 603-bis (c.d. caporalato) e 629 (estorsione aggravata), c.p., ai danni dei propri dipendenti, insegnanti di scuola secondaria.
L’imputazione era quella di aver sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, costringendoli, altresì, a restituire le retribuzioni ricevute, ovvero a lavorare sottopagati, con minaccia consistita nel prospettarne la mancata riassunzione in occasione di successivi rinnovi contrattuali.
In tale fattispecie, sussiste l’esclusione dell’applicabilità del reato di sfruttamento al lavoro intellettuale; la Suprema Corte, infatti, in svariate pronunce, ha, anzitutto, concisamente ricordato che la fattispecie penale è stata introdotta allo specifico fine di reprimere l’allarmante fenomeno del caporalato agricolo, soprattutto nelle campagne meridionali, che aveva dato luogo, quale immediato antefatto, allo sciopero dei lavoratori migranti occupati come braccianti.
L’iter storico della disciplina era già stato ripercorso compiutamente nella sentenza 45615/202 secondo cui l’arresto qui esaminato fa riferimento, ove si era precisato che il Legislatore, attraverso il D.L. 138/2011, ha inserito nel Codice penale il delitto dicui all’articolo 603-bis, al fine di colmare quello spazio vuoto di tutela creatosi fra il confine, da un lato, della grave ipotesi di riduzione in schiavitù e tratta degli esseri umani, di cui all’articolo 600, c.p., riformato già con la L. 228/2003 (norma che punisce assai gravemente la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, includendo nell’ipotesi di riduzione in servitù anche forme di lavoro forzato o obbligatorio) e, dall’altro, quello degli illeciti contravvenzionali, di effimero disvalore penale, previsti dalla Legge delega 30/2003 (c.d. Legge Biagi), poi attuata con l’emanazione del D.Lgs. 276/2003.
L’articolo 603-bis, c.p., nella sua originaria formulazione, puniva chiunque svolgesse:
“un’attività organizzata di intermediazione, reclutandone manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”.
La condotta tipica, dunque, era solo quella di intermediazione e, come aveva da subito notato la dottrina, inspiegabilmente, veniva sanzionata solo una fattispecie ristretta di sfruttamento, ovvero quello violento, e il datore di lavoro poteva solo concorrere nel reato con l’intermediario.
Modalità più diffuse e subdole di sfruttamento, attuate senza ricorrere necessariamente alla violenza, alla minaccia o all’intimidazione, venivano lasciate alla blanda gestione di un sistema penale più mite, quello predisposto attraverso le ipotesi contravvenzionali previste in tema di intermediazione illecita, ex articolo 18, D.Lgs. 276/2003.
Inoltre, la mancata previsione della responsabilità degli enti sembrava ignorare che, nella realtà, il fenomeno del caporalato è schermato da agenzie di intermediazione o società cooperative, e come le stesse imprese utilizzatrici siano gestite da soggetti collettivi.
L’intervento legislativo operato con la L. 199/2016 ha, infine, riformulato la fattispecie di cui all’articolo 603-bis, c.p., prevedendo un alleggerimento sostanziale della tipicità, così da ampliare la sua sfera di operatività e favorire una più agevole praticabilità processuale, distinguendo l’ipotesi di intermediazione illecita, il c.d. “caporalato”, configurandolo come delitto di pericolo a dolo specifico, da quella di sfruttamento del lavoro, condotta propria del datore di lavoro, equiparandole sul piano sanzionatorio.
RISOLUZIONE SECONDO NORMA
Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento, la lettura rigorosa della norma incriminatrice, offerta dalla sentenza in commento, ha destato diffuse perplessità, poiché l’esplicita esclusione delle prestazioni di lavoro intellettuali dal campo di operatività dell’articolo 603-bis, c.p., può avere un impatto significativo nell’applicazione pratica del delitto di sfruttamento del lavoro.
La Corte pare, poi, non tenere conto delle evoluzioni ermeneutiche più recenti della disciplina normativa, originariamente sì prevista per la repressione del c.d. caporalato, in primis agricolo, ma successivamente estesa dalla giustizia di merito e di legittimità a settori produttivi diversi da quello agricolo e a fattispecie più complesse e sofisticate di sfruttamento delle prestazioni lavorative.
Si tratta delle c.d. forme di caporalato “grigio”, o “digitale”, di cui, ad esempio, alla celebre sentenza n. 2805/2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Gup presso il Tribunale di Milano, nell’ambito del noto caso Uber (relativo allo sfruttamento dei ciclo-fattorini impiegati nella consegna di cibo a domicilio), che ha rappresentato il primo caso di applicazione della fattispecie prevista dall’articolo 603-bis, c.p., a un’ipotesi di caporalato digitale, ricalibrando i confini applicativi della fattispecie in relazione alle più moderne forme di sfruttamento.
RISOLUZIONE CASO PRATICO
Nella vicenda in oggetto, dunque è stato giudicato radicalmente insussistente il contestato reato di caporalato, con riferimento ai rapporti contrattuali e al tipo di attività lavorativa descritta nel capo d’imputazione, ed è stata riservata espressamente l’applicabilità alla sola manodopera manuale, in ambito agricolo, artigianale o industriale.
Questa conclusione si fonda su un’interpretazione sistematica della norma, la quale, nel delineare la condotta tipica del reato, richiede la sussistenza di specifici elementi oggettivi e soggettivi, in primis l’intermediazione illecita finalizzata allo sfruttamento del lavoro altrui, caratterizzata da condizioni di grave vulnerabilità o da una significativa sproporzione tra le prestazioni rese dal lavoratore e le condizioni economiche o contrattuali a lui riservate.
La Corte precisa, tuttavia, che l’esclusione del lavoro intellettuale dall’ambito di applicazione dell’art. 603bis c.p. non comporta l’impossibilità di contestare eventuali irregolarità o abusivismi. Tali condotte, ove sussistenti, devono essere valutate alla luce di altre norme più adeguate a disciplinare le peculiarità del lavoro intellettuale.Come è stato osservato, è necessario affiancare alla norma penale misure proattive volte a consolidare la protezione delle condizioni di lavoro, rafforzando il rispetto delle normative sul lavoro e promuovendo politiche di prevenzione dello sfruttamento. Questo approccio integrato, oltre a migliorare le condizioni dei lavoratori, contribuirebbe a smantellare le strutture sistemiche che favoriscono il proliferare di fenomeni di sfruttamento, rendendo più efficace e incisivo l’intervento normativo complessivo.